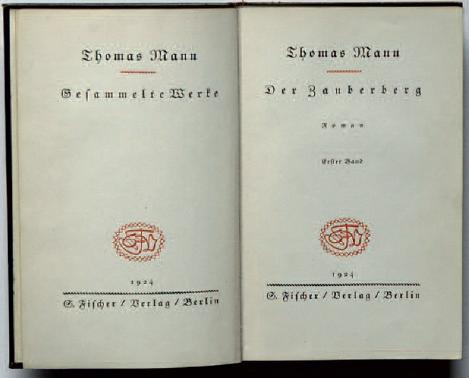Quadrando il circolo: la Matematica in Thomas Mann
Altezza Reale
Narrano le cronache rosa che nel 1904 Thomas Mann incontrò a Monaco di Baviera Katja Pringsheim – giovane benestante, figlia di un professore di Matematica e Fisica dell’Università, lei pure appassionata delle medesime discipline – e prese a corteggiarla. Nonostante qualche iniziale freddezza e ritrosia da parte di lei, la sposò nel febbraio 1905. Narrano sempre le cronache che la loro unione fu lunga e solida, “allietata” dalla bellezza di sei figli.
Si è soliti affermare che un matrimonio trasforma la vita; quello di Mann, se non altro, cambiò una trama. Mi riferisco ad Altezza Reale, che fu il primo romanzo che Mann completò dopo I Buddenbrook. La storia si ambienta in uno staterello tedesco dalle finanze dissestate, retto da un duca solitario e malinconico che in realtà delega il governo a un consiglio di nobili e notabili e gli uffici di rappresentanza al fratello, il principe Klaus Heinrich, il protagonista principale. Era forse intenzione originaria di Mann dedicare il romanzo al resoconto della crisi irreversibile di quel Paese. Ma la versione finale che oggi leggiamo, quando giunge verso la sua metà, ha una svolta imprevista e procede in tutt’altra direzione. Si immagina infatti che arrivi da quelle parti un facoltoso ospite ebreo americano – il signor Spoelmann – accompagnato dalla figlia Imma, studentessa di Matematica; che il visitatore decida di trattenersi per curarsi alle terme locali; che il principe Klaus Heinrich conosca così la giovane Imma, prenda a corteggiarla e, nonostante qualche prolungata freddezza e ritrosia da parte di lei, la sposi e riassesti così, grazie alle ricchezze del suocero, perfino il bilancio statale. Insomma, un finale fiabesco che sorprende e sconcerta l’assiduo lettore di Mann.
È allora corretto desumere che la modifica dell’intreccio e il personaggio stesso di Imma Spoelmann siano stati ispirati a Thomas Mann dall’incontro con la futura moglie, avvenuto durante la composizione dell’opera. Del resto il racconto ospita anche digressioni matematiche, che invece nei Buddenbrook erano sostanzialmente assenti, novità che non sorprende più di tanto visto che questi incisi servono evidentemente a descrivere le propensioni scientifiche della protagonista Imma Spoelmann; anzi è di nuovo lecito ipotizzare che siano essi pure largamente autobiografici.
Si comincia dunque con il sussurrare che la Spoelmann “studia come un uomo: Algebra e altre cose difficili”. Si narra poi della protagonista che corre impettita alle sue lezioni universitarie, con “l’Algebra sotto il braccio”, e non si cura nel suo procedere di impacciare una sfilata di granatieri. È in quell’occasione che il principe la nota per la prima volta: il racconto di Mann è qui sorridente e divertito ed è facile cogliervi l’emozione del ricordo personale. Del resto le cronache ci confermano che l’episodio fu direttamente ispirato da uno dei primi incontri dello scrittore con Katja Pringsheim. Tornando a Klaus Heinrich, il suo interessamento per l’ospite straniera si fa benevolo e cortese, come testimoniato dalla conversazione che segue:
“– E i suoi studi, signorina? È permesso informarsi? Matematica, è vero? Non è molto difficile? Non è uno sforzo terribile, per il cervello?
– Niente affatto. Non saprei immaginare niente di più divertente. È un gioco dell’aria, per dir così. Anzi addirittura fuori dell’aria”.
La citazione racchiude, appunto, l’aforisma famoso che definisce la Matematica “un gioco dell’aria”. Il corteggiamento intanto prosegue e il principe prova a invitare l’ospite a una passeggiata a cavallo. In quell’occasione, però, gli capita di adocchiare il quaderno di appunti matematici dell’amata. La descrizione che ne segue è altrettanto celebre. Illustra infatti alla perfezione l’impressione prodotta in un profano dalla visione dei simboli matematici, dipinti con dovizia di particolari come “fantastici geroglifici”, “segni cabalistici”, “sillabe strane”, “parole misteriose”, “colonne negromantiche”, “formule magiche”, tant’è che alla fine il principe non sa trattenersi dal domandare alla Spoelmann:
“– E per amore di queste arti scomunicate lei vorrebbe perdere questa bella mattinata?”.
Reazione che ben sottolinea il disappunto dello spasimante che si vede “scavalcato” da incomprensibili numeri e formule. Se perfino la terribile Matematica giunge a divenire tollerabile quando è trasfigurata dal sogno d’amore, la stessa Matematica, se esula dal proprio ruolo, espande il proprio spazio e osa impacciare Cupido, torna a esser vista con preoccupato sospetto.
Il piccolo signor Friedemann
Un matrimonio trasforma la vita, si diceva. Ma a onor del vero è azzardato sostenere che l’attenzione per la Matematica derivò a Mann solo dall’incontro con la futura moglie. Infatti già uno dei suoi racconti giovanili, Il piccolo signor Friedemann del 1897, accenna sia pure di sfuggita a un tema impegnativo come la Geometria non euclidea. Narra infatti di uno studente di Matematica che, durante un incontro conviviale, espone “con foga” questa novità sostenendo che “a partire da un punto si può tracciare più di una parallela a una retta”; né l’incredulità dei suoi interlocutori vale a scoraggiarlo, ché anzi insiste a provare la sua tesi “con tanta persuasione che tutti fingono di aver capito”. Resoconto breve e incisivo che rivela, se non proprio le teorie rivoluzionarie di Bolyai e Lobacevskij, certamente un’acuta percezione delle reazioni che la Matematica – euclidea e non – suscita negli uditori comuni, siano essi principi o plebei.
Ora, non bastano certo fondamenti così esili a designare Mann come un autore “matematico”, meno che mai se confrontato con suoi colleghi della stessa lingua e più o meno della stessa epoca come Musil e Broch. D’altra parte si deve pure riconoscere che Mann mai trascurò nel suo “mestiere” di scrittore la dovuta attenzione ai progressi della scienza e al contrario avvertì sempre l’esigenza, oserei dire il piacere, di un aggiornamento scrupoloso. Basti qui ricordare l’arguto intermezzo delle Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull in cui il professor Kuckuck, luminare di Paleontologia, intrattiene un compagno di viaggio in treno elargendogli una conferenza improvvisata, prolungata e approfondita sulla natura, sull’universo e sull’uomo, coniugandovi spunti di Biologia, Cosmologia, Fisica nucleare e quant’altro, incluso un pizzico di Geometria. Thomas Mann impiega qui un tono scherzoso e leggero – per quanto può riuscire leggera la conversazione di un cattedratico che espone le sue dottrine – ma le teorie che il professore sviluppa sono ampie, articolate, aggiornate e plausibili.
Si è poi soliti individuare tra i massimi leitmotiv dell’opera manniana l’intrico inquietante tra arte e decadenza, tra creatività e malattia, come se la seconda fosse il rovescio della medaglia della prima, il dazio inderogabile da pagare per ottenerla. Qualche lettore potrà a questo punto rilevare come l’argomento, a dispetto del suo indubbio fascino, abbia poco a che spartire con scienza e Matematica. Ma a pensarci bene, che cosa c’è di più toccante e agghiacciante del resoconto che Mann fa ne I Buddenbrook della morte di Hanno? Eppure quel racconto è redatto in termini assolutamente oggettivi e scientifici, distaccato e asciutto come una voce dell’enciclopedia della salute: “nel tifo le cose si svolgono così…”. Insomma, si limita alla fredda esposizione di sintomi e diagnosi e ciò nonostante, o forse proprio per questo, acquista un pathos e diventa il modo più espressivo di descrivere decadenza e disfacimento. Non è poi forse vero che il binomio inquietante che contrappone creatività e malattia o follia sussiste anche in Matematica, ampiamente testimoniato da esempi celebri quali Gödel, Cantor, Turing, Galois e molti altri? E, tornando ad Hanno Buddenbrook, sarebbe davvero improponibile un paragone tra il suo destino e per esempio quello del giovane Abel, ambedue condannati a una morte prematura nella grigia atmosfera di una città nordica? Del resto, anche nel caso di Abel, la passione e il talento per l’arte matematica ebbero a coniugarsi con un’esistenza grama di malattie e di stenti.
Insomma, Mann è autore troppo complesso perché l’argomento “matematico” si possa licenziare a suo proposito in modo sbrigativo. Sembra anzi lecito approfondire fino a che punto le predilezioni scientifiche della moglie, e comunque la sensibilità e la curiosità intellettuale di Mann, sostennero una familiarità per la Matematica. Esistono dunque in altri racconti e romanzi, a prescindere da quelli già citati, intermezzi matematici? Se sì, sono soltanto parentesi isolate, flash slegati e disordinati, o ammettono un qualche filo logico a congiungerli?
La montagna incantata
Conviene procedere con cura, raccogliendo anzitutto dall’opera di Mann le opportune citazioni. Di Altezza Reale si è già detto. Proseguiamo allora con La montagna incantata, un altro dei capolavori che valsero allo scrittore tedesco il Nobel per la Letteratura. Anche qui fa capolino un minimo di Matematica, per la precisione il classicissimo problema di “quadrare il circolo”, cioè di costruirlo a partire dal raggio con l’aiuto di riga e compasso. Si tratta in definitiva di stabilire se pi greco – il rapporto costante tra l’area di un cerchio e quella del quadrato che ha per lato il raggio – sia un numero razionale o almeno algebrico di grado una potenza di due. Ad affrontare l’argomento è nel romanzo uno dei personaggi minori, il consigliere Paravant. È questi uno degli ospiti del sanatorio sulle Alpi svizzere dove si ambienta la trama, malato di tubercolosi come gran parte dei suoi compagni di sventura e come loro alla ricerca nell’aria fina di quei monti di un sollievo, se non addirittura della guarigione. Ebbene, a quel che ci riferisce Mann, il passatempo che egli sceglie per riempire i lunghi mesi di cura, quello “al quale dedica tutti i suoi pensieri, di giorno e di notte, al quale consacra la perseveranza e tutta la tenacia”, è appunto “la quadratura del circolo”. Quale sia il motivo di tanto entusiasmo, non è chiarissimo. Qualche malato sussurra che lo studio della Matematica serva al Paravant come antidoto contro l’isolamento e rimedio contro la concupiscenza: lui, “che va sempre in tentazione, vi si è buttato a corpo perduto e ora, studiando la quadratura del cerchio, si sente molto sollevato”. In ogni caso, che questa o altra ne siano le ragioni, Paravant si abbandona alla Matematica e al pi greco con passione e dedizione assolute. Il guaio è che, come ancora Mann ci racconta, “lo sviato funzionario era arrivato alla convinzione che le prove, con le quali la scienza pretendeva di aver dimostrato l’impossibilità della costruzione [del cerchio], non erano valide”. Così i suoi sforzi sono tutti rivolti a smentire la perversa dottrina dell’irrazionalità di pi greco, ad accumulare calcoli e disegni capaci di sgretolare quella ingannevole certezza e a ragguagliare costantemente gli altri pazienti delle proprie ambasce e dei propri progressi. Una mania insomma, una fissazione, più innocente di tante altre, ma non per questo meno incresciosa.
Mann si mostra quindi nella sua narrazione perfettamente aggiornato sull’irrazionalità, se non sulla trascendenza, di pi greco e anzi riferisce dei tentativi di calcolarne lo sviluppo decimale aggiungendo per altro che quegli sforzi sono “per puro lusso, perché la possibilità di avvicinarsi all’irraggiungibile esattezza non si esaurirebbero neanche con duemila cifre, e anzi rimarrebbero tali e quali”. Il suo racconto è comunque ironico e divertito e il ritratto che se ne ottiene del consigliere Paravant felicissimo.
Frontespizio della prima edizione in lingua originale de "La montagna incantata" (1924)
Giuseppe e i suoi fratelli
L’opera di gran lunga più vasta, se non più complessa, di Thomas Mann è la tetralogia di Giuseppe e i suoi fratelli. Ricorderete la storia del personaggio biblico così come ci viene proposta dalla Genesi: “figlio della vecchiaia” di Giacobbe, giovane “bello di forma e avvenente di aspetto”, Giuseppe attira la predilezione del padre e quindi l’invidia dei fratelli maggiori i quali, non appena se ne presenta l’occasione, lo malmenano e lo vendono schiavo a una carovana di mercanti. Arrivato così in Egitto, Giuseppe sperimenta prima la schiavitù e poi anche la prigione ma con il tempo ottiene, grazie alle sue doti e all’aiuto divino, l’affrancamento e il favore del Faraone e si ricongiunge finalmente con i fratelli – debitamente perdonati – e con il padre.
Così può riassumersi lo stringato racconto della Bibbia. Ma il romanzo di Mann lo amplifica e riverbera, confrontandolo con analoghi miti e tradizioni di altre antiche culture. Si sofferma poi in particolare sulla figura del protagonista: visto non più come santo e irreprensibile paladino del bene, pio, candido e angelico, trionfatore di ogni disgrazia perché forte dell’aiuto divino; ma come giovane, sì amabile e pieno di grazia, tuttavia ambiguo, talora narcisista, “astuto come il serpente e mansueto come la colomba”, “perfido nell’innocenza e innocente nella perfidia”, tenace programmatore della propria scalata al successo, quasi un moderno social climber o un rampante “cavaliere d’industria”; ricco sì di doti e talenti, accorto tuttavia a volgere a suo vantaggio la sua scienza, le sue belle maniere e la sua naturale “abilità nell’augurare la buona notte”; forte sì di una dirittura interiore e di una saldezza morale che non si piegano neppure nelle tentazioni e nelle disgrazie, ma tutto meno che spirito tormentato dalla ricerca di Dio; rispettoso sì delle fede dei padri, sicuro del favore dell’Altissimo, eletto da Dio, inviato di Dio, ma di conseguenza dedito pure al culto e al mito di sé stesso. Per usare una similitudine matematica proposta dallo stesso Mann, la natura di Giuseppe si potrebbe forse descrivere come una strana miscela di bene prevalente ma non assoluto, come una somma algebrica dal valore positivo ma non scevra di addendi negativi o ambigui. Sostiene tuttavia Mann, a prevenirci che il paragone regge solo fino a un certo punto, che le leggi del calcolo non bastano a chiarire le sottigliezze psicologiche: “il puro computo aritmetico non ha colori”.
Questo è dunque il modo in cui Mann ci presenta Giuseppe. Ma, per tornare a noi e al tema specifico di queste note, è giusto enfatizzare come tra le capacità che assistono il protagonista nella sua irresistibile risalita stia proprio la conoscenza della Matematica, la sua “arte di trasformare lo zero in due”. Intendiamoci: la Matematica di Giuseppe si conforma alla sensibilità di quei tempi antichi, non disdegna quindi di mescolarsi a religione e Astrologia e studiare i “miracoli numerici di Dio” e i “sacri numeri cosmici”, s’ammanta in conclusione di valenze magiche e cabalistiche. In compenso risultano attualissime le predisposizioni matematiche dei fratelli, i quali “tutti senza eccezione reputavano addirittura un onore non fare alcun conto e non capire nulla di quanto avesse a che fare con il sapere e la parola”. Delle abilità matematiche di Giuseppe sembra allora corretto, senza scendere in troppi dettagli, presentare almeno un paio di esempi.
Il primo riguarda un colloquio con il padre Giacobbe, quando il giovane cerca di giustificare con il genitore la sua venerazione quasi pagana per la luna. Rileva dunque Giuseppe che “sette volte cinquanta giorni compongono il ciclo dell’anno più quattro giorni”; dunque 354 sarebbero stati, secondo le convenzioni di quell’epoca, i giorni dell’anno. Aggiunge poi che “in ogni mese ci sono tre giorni in cui gli uomini non vedono la luna”, così che una semplice operazione, 354 – 12 × 3, rivela il numero delle notti in cui la luna è visibile nel corso dell’anno, ovvero 318. Ora, prosegue Giuseppe, 318 è anche il numero dei servi che aiutarono il bisnonno Abramo a vincere un suo combattimento contro i re d’Oriente. Si deduce che perfino l’avo Abramo “amò tanto la luna e le era tanto devoto da volere che il numero dei suoi servi per la battaglia corrispondesse esattamente al numero dei giorni in cui la luna risplende”: conclusione che esemplifica perfettamente quella commistione tra numeri, astri e cabala di cui già si diceva.
Molto più terrena è l’altra citazione, tratta dal primo colloquio di Giuseppe con il mercante che l’ha comprato dai fratelli. È qui che l’abilità aritmetica del giovane comincia a suscitare nel padrone compiacimento e meraviglia. Ecco infatti in dettaglio il dialogo tra mercante e Giuseppe.
“– Quante volte sette sta in settantasette? Due volte, vero?
– Due volte solo secondo la scrittura. Ma secondo il ragionamento devo prendere il sette una volta, poi due, e poi otto, e così arrivo a settantasette, perché sette, quattordici e cinquantasei è il risultato. Ma uno, due e otto fanno undici, e così sette sta undici volte in settantasette.
– Così presto sai trovare un numero nascosto?
– Presto o mai”.
Il racconto di Mann ci propone tra l’altro in modo esemplare gli antichi metodi per svolgere le operazioni, nella fattispecie la divisione. Il colloquio con il mercante poi prosegue e Giuseppe ha modo di esplicarvi la sua abilità anche nella soluzione delle equazioni e nel calcolo delle aree. Non solo l’Aritmetica e l’Algebra, ma anche la Geometria anima le sterminate pagine del Giuseppe, né la circostanza sorprende più di tanto. Avviene infatti, come è prevedibile, che la carovana di mercanti che procede verso il centro dell’Egitto e la capitale Tebe incontri le piramidi, che Mann descrive come “cattedrali triangolari”, “stereometrici monti funebri”, con toni in verità vagamente enfatici e altisonanti. Più avvincente e fascinosa è la descrizione incantata delle meravigliose metropoli egiziane che Giuseppe attraversa al seguito dei suoi padroni. Il racconto di Mann qui ricorda e anticipa per certi versi le Città invisibili di Calvino. Colpisce in particolare l’ordinata struttura geometrica della millenaria On, la città del Dio Sole, dipinta quasi come una polis ideale del nostro Rinascimento. Il motivo geometrico dominante in On è nuovamente il triangolo. On stessa è “città costruita in forma di triangolo” ed è anzi un “grande obelisco” a rappresentarne il culmine, ovvero “il punto di convergenza e d’intersezione dei lati”. La figura del triangolo da un lato richiama il vicino delta del sacro fiume Nilo, dall’altro ci illustra la religione di On spiegandoci come essa concilî un apparente politeismo – “l’effettiva molteplicità degli dei d’Egitto” – con un sostanziale monoteismo. “Essi – i sacerdoti del Dio Sole – vi riuscivano con la scienza del triangolo” [rettangolo]. “All’ipotenusa (…) corrispondevano gli dei dai molti nomi e dalle molte figure che il popolo invocava, e al culto dei quali attendevano i sacerdoti nelle città dei Paesi. Ma sopra di essi si levavano i due lati della bella figura tendenti a convergere, i quali, infatti, s’incontravano in un punto, termine e intersezione delle loro linee, sotto il quale tutte le varietà e gli aspetti del simbolo continuavano a esistere, e tale punto era il Signore del loro tempio, era Atum-Râ”: il Dio Sole, “antichissimo” e tuttavia “mobile e lietamente aperto al mondo e alla vita”.
C’è un’altra figura geometrica cui Mann dedica alcune pagine tra le più belle e famose del suo Giuseppe ed è la sfera, non tanto per le sue proprietà matematiche o per il calcolo del pi greco ma per le sue inquietanti valenze. La sfera infatti è perfettissima eppure ambigua, “al tempo stesso eternità e prigione”, per dirla con le parole di Chesterton. La prosa di Mann illustra esaurientemente ambo i poli di questa antitesi. Prigione, anzitutto.
“Il mondo ha parecchi centri, uno per ciascun essere, e intorno a ciascun essere gira un mondo nella sua sfera. Tu sei distante da me solo mezzo cubito, ma intorno a te gira un mondo il cui centro non sono io ma tu. Io però sono il centro del mio”.
Così si esprime Giuseppe in un dialogo con il figlio del padrone mercante, a sottolineare l’umana incomunicabilità e la difficoltà di immedesimarsi coi pensieri e sentimenti altrui. È vero che Giuseppe provvede subito dopo a smorzare ogni attrito, esercitando la sua diplomazia e le buone maniere e affermando: “Quindi ambedue diciamo il vero, sia che tu parli dalla tua postazione, sia che io parli dalla mia. I nostri mondi non sono così lontani fra loro da non toccarsi”. È pure vero che il suo interlocutore non capisce più di tanto queste sottigliezze e anzi le cataloga tra i sofismi logici da evitare. Resta però l’immagine della sfera come una metafora della solitudine e appunto dell’umana incomprensione, come se il nostro mondo sia solo una collezione sterminata di sfere – altrettanti atomi, isole o prigioni – drammaticamente esterne l’una all’altra oppure talvolta tangenti e perfino secanti, ma mai completamente sovrapposte. I passi più attraenti e profondi che il Giuseppe dedica alla sfera si riferiscono tuttavia all’estremo opposto dell’eternità e dell’infinito. Mann si rifà qui ad antiche teorie astronomiche babilonesi per indagare la storia e la filosofia del mito. Scrive allora nel primo libro della sua opera, e cioè nelle Storie di Giacobbe, che “nell’infinità del passato (…) ogni origine si rivela un appiglio apparente, una meta non definitiva” e non c’è nessun punto fisso o fatto stabilito da cui procedere. Passa poi a spiegarne il motivo.
“La natura misteriosa dell’origine si fonda sul fatto che la sua essenza non è la linea, ma la sfera. La linea non ha misteri. Il mistero inerisce alla sfera”
perché risiede nella duplicità di questa figura, nei due emisferi che la compongono, “due metà che vanno a formare un tutto unico”, una superiore e una inferiore, una celeste e una terrestre. Infatti “la sfera gira – è nella sua natura” ed è così che il celeste diventa terrestre e il terrestre celeste, trascendenza e immanenza di confondono, gli uomini divengono dei e gli dei uomini, la storia mito e il mito storia. La riflessione è ripresa nel libro successivo del ciclo, Il giovane Giuseppe, dove si legge che “la sfera si volge, e non si potrà mai stabilire dove una storia abbia la sua origine: se in cielo o in terra. Si pone al servizio della verità chi dichiara che tutte le storie si corrispondono e si svolgono contemporaneamente in un luogo e nell’altro, e che solo al nostro occhio sembrano discendere in terra e poi di nuovo ascendere in cielo. Le storie discendono quaggiù, come un dio diventa uomo, si fanno terrene in un processo per così dire di imborghesimento”.
In questo modo mito e religione, dunque la storia stessa dell’origine dell’uomo, si rivelano come sfere o circoli da quadrare e la chiave del loro mistero – il loro pi greco – ancora di là da decifrare.
Doctor Faust
Il Doctor Faustus è una delle opere della maturità di Mann: riprende il tema chiave del rapporto tra arte e decadenza, riferendolo stavolta all’ambito musicale. Il protagonista è infatti Adrian Leverkühn, musicologo e musicista, il quale stringe con il diavolo un patto per garantirsi ispirazione compositiva e genio creativo, e in effetti li ottiene, ma solo al prezzo della malattia, del decadimento fisico, della demenza e della morte. L’itinerario esistenziale di Leverkühn, collocato nel primo Novecento, diventa poi, nella riflessione dell’amico e narratore Zeitblom che lo riferisce a distanza di qualche anno, la metafora della disgregazione morale e della sconfitta della Germania hitleriana. Ma prescindiamo qui da ogni paragone storico e politico e concentriamoci piuttosto sulla Matematica nel Doctor Faustus. L’esercizio è più agevole e naturale che in altre opere di Mann, vista la conclamata affinità che si è soliti individuare appunto tra Matematica e Musica.
Tratti matematici rivela, tanto per cominciare, la figura di Leverkühn. In realtà il protagonista non viene mai ritratto per esteso, ma piuttosto dipinto con rapidi tocchi sparsi qua e là nel libro. Ci appare complessivamente come uno spirito appartato, non privo di ironia ma “freddo, enigmatico e chiuso”, capace di sviluppare contatti umani soltanto entro il “limite di comunicazione e di confidenza di cui è capace la solitudine”, per il resto votato a una “ascetica rinuncia ad ogni avvicinamento diretto” e a una “rigorosa osservanza del mistero, del ritegno, della lontananza”: non dissimile in tutto questo da un intellettuale matematico, quale la gente di solito se lo raffigura.
Non stupisce poi di incontrare, nella lettura del romanzo, frequenti intermezzi di sapore matematico. Già il narratore Zeitblom, che pure si professa umanista, manifesta tuttavia ammirazione sincera, quasi rimpianto, per l’antica scuola pitagorica e per l’utopia di un’Aritmetica che è fulcro supremo della realtà, non puro e arido calcolo formale ma principio ispiratore e chiave rivelatrice del mondo e delle stelle, cabala e vaticinio, quasi divinità e comunque regola morale, ordine e armonia, nonché ovviamente fondamento della Musica. Ma quello che in Zeitblom è entusiasmo candido e solare, in Leverkühn diviene un sentimento assai più ambiguo e sottile. La “sua” Matematica continua a confondersi, come già in Giuseppe, con Teologia, Magia, Astrologia e, ovviamente, Musica, ma in forma più complessa e consapevole e per certi versi torbida.
Leverkühn infatti palesa sin da ragazzo di apprezzare la precisione formale e il nitore della Matematica, ma anche di gradirne valenze più spirituali e riposte (“il giuoco santo e razionale dei numeri”). Del resto anche della Musica gli capita di affermare che è “un’unione magica di teologia e di matematica divertente” oppure di compiacersi, a proposito dell’antica scala tonale tolemaica, che “fosse stato proprio un astronomo e matematico [Claudio Tolomeo, appunto] a fissarla”. Leverkühn coltiva per altro nella composizione musicale il gusto, che già fu di Bach, di celare scritture cifrate, di sovrapporre al tema principale livelli e significati superiori, di “racchiudere nelle proprie opere formule e simboli misteriosi che rivelano la congenita tendenza della musica a celebrazioni e riti superstiziosi attraverso numeri mistici e lettere simboliche”.
Tornando specificamente alla Matematica, Leverkühn osserva già in età giovanile che “non esiste niente di meglio che osservare relazioni di ordine” e anzi che “un ordine sciocco è sempre meglio di niente”; affina poi, in anni più maturi, queste sue convinzioni sviluppando una teoria musicale, che va in sostanza a corrispondere, nella realtà storica, alla dodecafonia di Arnold Schönberg. Ricorderete che, secondo quel metodo di composizione, ciascuna delle dodici note – dal do al si, inclusi diesis o bemolle – acquista pari dignità e concorre all’esito complessivo. Si richiede cioè espressamente che tutti i suoni della scala cromatica compaiano con la stessa frequenza e anzi si succedano in sequenze o “serie” che li contengano una e una sola volta senza eccezioni. È tuttavia ammessa la possibilità di permutare queste serie, di adottarne versioni “retrograde” in cui le note procedono dall’ultima alla prima oppure “inverse”, in cui gli intervalli discendenti divengono ascendenti e viceversa, o altre ancora.
Queste teorie condivide, e anzi partorisce nella finzione, Leverkühn, che le celebra come “una totale organizzazione razionale di tutto il materiale musicale, che abolisca le appropriazioni anacronistiche ed eviti che un elemento diventi mera funzione dell’altro”, ancora come “obiettività e composizione rigorosa” e come “forma di estremo rigore, che non conosce più niente di extramatematico” così che tutto sia “legato con la voluta costrizione dell’ordine” e “dunque libero”. C’è un paragone matematico che Mann insinua a illustrare queste idee, ed è quello dei quadrati magici: matrici numeriche in cui ogni cifra deve comparire una e una sola volta, come me già una nota di una serie dodecafonica, e inoltre la somma di ogni riga, colonna e diagonale deve mantenersi costante. Quindi i quadrati magici sono ordinatamente costruiti in ossequio a principi rigorosi, tanto che la Matematica ce ne propone addirittura teoremi di classificazione, ma al tempo stesso rappresentano un gioco di fantasia e inventiva, libero e creativo, aperto a permutazioni e rielaborazioni retrograde e inverse. Tra gli esempi più famosi che li riguardano c’è quello dipinto da Dürer nella sua Melancholia. Ebbene, un quadrato analogo ci viene presentato con dovizia di dettagli da Mann nella descrizione della stanza dove vive Leverkühn quando è giovane studente ad Halle: suddiviso in 4 righe e 4 colonne, dunque in 16 caselle numerate “di modo che l’1 appariva in basso nell’ultima casella a destra, il 16 in alto a sinistra; e la magia – o stranezza – consisteva nel fatto che questi numeri, comunque si sommassero, dall’alto in basso oppure orizzontalmente o in diagonale, davano sempre la somma di 34. Su quale principio di ordinamento si fondasse questo risultato magicamente uniforme non sono mai riuscito a scoprire [così confessa il narratore Zeitblom] ma non fosse altro per i l posto eminente che [Leverkühn] aveva assegnato a quel foglio (…), esso attirava sempre l’attenzione, e credo di non aver mai fatto una visita in quella stanza senza che un mio rapido sguardo controllasse, in senso orizzontale od obliquo o per diritto dall’alto in basso, quella singolare esattezza”. Come Mann osserverà molte pagine dopo, lo stile e la tecnica musicali che il protagonista elabora di lì a qualche anno sono, appunto, una sorta di quadrato magico “che svolge massima varietà da motivi identici e fissi, dove non vi è più nulla di extramatematico, nulla che non possa considerarsi variazione d’un motivo sempre uguale”.
La morte a Venezia
È giunto il tempo di tirare le fila e trarre, se possibile, qualche conclusione. Si deve allora prendere atto della curiosità, dell’attenzione e del rispetto che le opere di Mann – dai racconti giovanili ai romanzi più maturi – riservano alla Matematica, tanto più considerevoli e apprezzabili se confrontati con certi atteggiamenti boriosi che allo stesso proposito manifestano altri autori anche moderni, non dissimili in questo dai commensali del piccolo signor Friedemann e dai fratelli di Giuseppe.
Vale forse la pena di citare qui un aneddoto della vita di Mann, riferito da Costance Reid nella sua biografia del matematico Richard Courant. Riguarda l’altro romanzo di Thomas Mann che ha titolo italiano Carlotta a Weimar. Esso narra di Goethe che, in età matura, incontra di nuovo colei che gli aveva ispirato in gioventù l’eroina femminile de I dolori del giovane Werther. Si racconta che, per l’edizione inglese del suo lavoro, Mann fosse incerto se mantenere il titolo originario Lotte in Weimar, altrettanto valido quanto in tedesco, oppure preferire l’alternativa che altri gli proponevano, The beloved returns. Ne accennò appunto a Courant durante una festa a Princeton e la risposta del matematico fu: “Se lo si pubblicherà come Lotte in Weimar, venderà diecimila, o forse ventimila copie; ma se sarà The beloved returns, allora di copie ne venderà centomila, e i diritti d’autore saranno in proporzione” – e Mann seguì quel consiglio. Al di là delle fortune editoriali del libro, l’episodio testimonia l’affinità naturale che spesso si instaura tra personaggi di mente aperta e cultura superiore, anche se di educazione ed estrazione diverse.
Leggiamo quindi in Mann intermezzi di Matematica mai banali, sempre documentati, spesso profondi, semmai velati, come in Giuseppe e nel Doctor Faustus, di valenze extrascientifiche, musicali, astrali e perfino magiche. Mai però questi excursus appaiono forzati e ingiustificati. Alla loro radice resiste piuttosto, per citare ancora Adrian Leverkühn, la visione di una Matematica quale “logica applicata che rimane tuttavia nella pura e alta astrattezza”, disposta a occupare “un singolare posto intermedio tra le scienze umanistiche e le scienze tecniche”, e quindi in definitiva espressione de “il vero”.
Certo, che cosa sia la verità (matematica o meno) è questione troppo complessa e delicata per aspettarsi risposta. Neppure il sistema di Euclide, meno che mai la Matematica magica, sono depositari del vero e Mann provvede spesso e bene a sottolinearlo.
Se servissero ulteriori conferme, basterebbe rileggere nelle Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull la “conferenza” già citata del professor Kuckuck e segnatamente quel passo dove il docente ironizza su quei “mistici della proporzionalità” i quali “pretendono che l’uomo (…) con la sua statura rappresenti l’esatta metà tra il mondo del molto grande e quello del molto piccolo”, che “il massimo corpo naturale entro l’universo, un gigantesco astro rosso, sia tanto più grande dell’uomo di quanto ne è piccola la minima componente dell’atomo”, critica spiritosa di una concezione della Matematica troppo miope, ingenua e antropocentrica.
Oppure si potrebbe considerare, a proposito di Giuseppe e i suoi fratelli, l’episodio famoso del sogno del Faraone: sette vacche grasse seguite da sette vacche magre. Sacerdoti e indovini di corte non sanno darne che spiegazioni incerte e balbettanti. Giuseppe invece lo interpreta come l’annuncio di altrettanti anni, prima di prosperità e poi di carestia; raccomanda allora di approfittare del periodo di ricchezza per affrontare quello di povertà; conquista così la completa fiducia e il favore del Faraone, che lo chiama anzi al governo dell’Egitto. Ma, si domanda Mann, fino a che punto si avverò realmente la predizione di Giuseppe? Furono esattamente sette gli anni grassi e quelli magri? O non si volle piuttosto che diventassero sette perché tanti ne aveva vaticinati Giuseppe? Le genti di quell’epoca, commenta lo scrittore, “erano animate dalla migliore volontà di questo mondo di vedere confermarsi la predizione seppure a grandi linee, e appunto per amore di questo avvera mento non andarono troppo per il sottile” disposte, per avvalorare la loro fiducia, a trascurare la precisione matematica e ammettere “che due più due faccia cinque” e che cinque diventi sette. Insomma, gli anni grassi forse non furono tutti grassi e quelli magri non tutti magri e magari gli uni e gli altri furono non sette, ma solo cinque. Tutto si avverò, ma solo “con l’imprecisione delle cose vive, e non con aritmetica e letterale esattezza”. La predizione si realizzò solo perché si voleva che si realizzasse. Furono dunque il sogno e il mito a sostenere la (loro) Matematica, e non viceversa.
Oppure, per passare a riferimenti più seri e compassati, si potrebbe ricordare quanto Mann annota, in una sua conferenza del 1936 su “Freud e l’avvenire”, che “una grande verità è una verità il cui opposto è anch’esso una grande verità” o ancora quel che leggiamo nel Doctor Faustus, che “una non-verità tale da aumentare energia può misurarsi con qualunque verità sterilmente virtuosa”; o ancora il passo de Il giovane Giuseppe in cui leggiamo che “nel mondo tutte le cose esistono in duplice forma e ognuna ha il suo contrapposto affinché possa distinguersi; e se vicino all’una non vi fosse l’altra, nessuna delle due esisterebbe”.
Citazioni che non riguardano direttamente la Matematica ma le si applicano facilmente e, come tali, vanno ben oltre l’ingenuo rimpianto della illusoria perfezione pitagorica oppure solo euclidea ma dischiudono almeno implicitamente gli orizzonti dei relativismi non euclidei e perfino gli imbarazzi aritmetici dei teoremi di Gödel, l’esistenza dunque di teorie geometriche alternative e antitetiche, e ciò nonostante credibili, oppure di sistemi aritmetici coerenti eppure incompleti, incapaci di dimostrare o confutare ogni ipotesi a proprio riguardo, di far luce totale sul proprio ambito – un po’ come il Tonio Kröger che “portava in sé possibilità per mille modi di esistenza, insieme alla segreta consapevolezza che, in fondo, si trattava di altrettante impossibilità”.

Locandina del film "Morte a Venezia" diretto da Luchino Visconti nel 1971
Per concludere però nel modo migliore queste note, vorrei citare un passo de La morte a Venezia che contiene il complimento più bello rivolto da Mann alla Matematica. La sceglie infatti come termine di paragone della gioventù e dell’amore. È venato di sottile melanconia ma, chissà?, forse pure di sottile ammirazione. Dice:
“Non diversamente dai matematici, che ai fanciulli inesperti mostrano emblemi tangibili di pure forme, del pari Amore, per rendere visibile ciò ch’è dello spirito, volentieri si serve della figura e del colore dell’umana giovinezza; e a farne uno strumento del ricordo, l’adorna di tutto lo splendore della beltà, e il nostro cuore allora, nel contemplarla, s’accende di dolore e di speranza”.