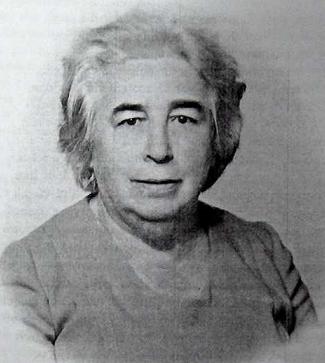Search
Bagnera Giuseppe

Giuseppe Bagnera era nato a Bagheria (Palermo) il 14 novembre 1865; è morto a Roma il 12 maggio 1927.
Si laureò a Palermo, in Ingegneria nel 1890 e in Matematica nel 1895, dove fu allievo di Ernesto Cesàro. Dopo alcuni anni passati nell'insegnamento medio, nel 1899 ottenne la libera docenza in Algebra e fu "spinto" dal suo maestro, Francesco Gerbaldi, a partecipare ai concorsi universitari. Nel 1901 fu nominato professore all'Università di Messina dove rimase sino al 1909, salvandosi dal terremoto del 28 dicembre 1908 perché, recatosi a Palermo a passarvi il Natale, la sera del 27 non riuscì a prendere il treno che avrebbe dovuto riportarlo a Messina appena prima di quella immane catastrofe! Dal 1909 al 1921 fu professore di Analisi all'Università di Palermo da dove, al principio del 1922, si trasferì a quella di Roma per impedire che la cattedra di Analisi cambiasse destinazione disciplinare.

Giuseppe Bagnera
La sua produzione scientifica è numericamente scarsa, ma di qualità eccellente. Si occupò principalmente di teoria dei gruppi finiti e, assieme a Michele de Franchis, di superfici algebriche e funzioni abeliane. Fu altresì autore di alcuni significativi trattati, in particolare il "Corso di Analisi Infinitesimale" pubblicato a Palermo nel 1915.
Fu socio dell'Accademia Lincei, premio Bordin dell'Académie des Sciences di Parigi (1909), professore onorario della Università di Washington.
Necrologio: "Rendiconti Lincei", Append. al vol. (6) 8 (1928), pp. XII-XX (F. Severi).
Brusotti Luigi

Luigi Brusotti era nato a Pavia l'11 settembre 1877; è morto a Padova il 30 aprile 1959.
Laureatosi a Pavia nel 1899, dopo un anno di perfezionamento a Pisa, fu per 5 anni assistente di Berzolari, Formenti e Aschieri all'Università di Pavia. Successivamente insegnò per 20 anni nelle scuole medie e in ultimo all'Istituto tecnico di Pavia. Nel 1926, in seguito a concorso, fu nominato professore di Geometria all'Università di Cagliari da dove, nel 1928, passò a Pisa e nel 1931 a Pavia, dove rimase sino al collocamento a riposo (1952).

Luigi Brusotti
Fu un geometra con brillanti qualità di semplicità, di chiarezza e di autonomia di pensiero. Fra le sue pubblicazioni, prevalgono quelle sullo studio di curve e superfici nel campo reale e tre magistrali articoli nell'Enciclopedia delle Matematiche Elementari. Oscar Chisini ha scritto di lui "Fu un vero signore dell'Ottocento con tutti i pregi di tale epoca ormai lontana".
Fu socio dell'Istituto Lombardo e dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
Necrologio: "Rendiconti Lincei", (8) 28 (1960), pp. 731-36 (O. Chisini); "Bollettino UMI", (3) 14 (1959), pp. 287-294 (V.E. Galafassi).
Nicoletti Onorato

Onorato Nicoletti era nato a Rieti il 21 giugno 1872; è morto a Pisa il 31 dicembre 1929.
Si laureò a Pisa (dove era stato allievo della "Normale") nel 1894 e, dopo un periodo di perfezionamento e breve insegnamento all'Istituto tecnico di Roma, nel 1898 fu nominato (in seguito a concorso) professore di Calcolo all'Università di Modena da dove, due anni dopo, tornò a Pisa per rimanervi sino alla precoce morte. Vi insegnò prima Algebra e poi, dopo la morte di Ulisse Dini, Calcolo infinitesimale.
I suoi lavori concernono sia l'Analisi algebrica sia quella infinitesimale. In Algebra, si occupò principalmente di alcune equazioni connesse con le matrici hermitiane e della convergenza di algoritmi iterativi di un tipo molto generale. Nell'Analisi infinitesimale, si interessò particolarmente della teoria delle equazioni differenziali, sia ordinarie sia alle derivate parziali. Si interessò pure molto di questioni didattiche e pubblicò, con vari collaboratori, apprezzati testi per le scuole medie.
Necrologio: Bollettino UMI, 9 (1930) p. 53 e pp. 121-124 (R. Marcolongo e F. Cecioni).
Orlando Luciano

Luciano Orlando era nato a Caronìa (Messina) il 13 maggio 1887; è morto in guerra, sull'Isonzo, il 21 agosto 1915. Era il padre di quello che poi sarà un noto giornalista televisivo, Ruggero, degli anni '60-'70.
Dapprima Ufficiale di carriera del Genio (dal 1900) nel 1903 si laureò in Matematica all'Università di Messina, dove fu alunno di Giuseppe Bagnera e di Roberto Marcolongo. Dopo un anno di perfezionamento a Pisa, divenne assistente e libero docente all'Università di Messina da dove, dopo il terremoto del 1908, passò a Roma, dove insegnò pure all'Istituto superiore di Magistero e alla Scuola Aeronautica degli specialisti del Genio. Partecipò senza esito ad alcuni concorsi universitari di Analisi e se ne dispiacque al punto che, quando nel 1915 partì per la guerra, alcuni suoi amici pensarono che avrebbe cercato la morte invece di schivarla. Morì da Capitano del Genio, guidando un'azione dei suoi minatori contro il ponte di S. Daniele presso Tolmino.
I suoi più importanti lavori concernono la Fisica matematica – in particolare la teoria della Elasticità – nonchè quella delle equazioni integrali, in cui fu uno dei primi a riconoscere l'importanza dei cosiddetti nuclei "degeneri" (detti di Pincherle-Goursat). Notevoli sono alcune sue ricerche algebriche a cui fu indirizzato dal suo maestro Bagnera.
Necrologio: Rendiconto Seminario Matematico Roma, n° speciale del 1918, pp. 11-15 (R. Marcolongo).
Baiada Emilio

Emilio Baiada era nato a Tunisi il 12 gennaio 1914; è morto a Modena il 14 maggio 1984.
Allievo della "Normale" di Pisa, si laureò (con il massimo dei voti e la lode) nel giugno del 1937 con Leonida Tonelli, del quale fu assistente dal 1938 al 1941, quando fu chiamato alle armi. Alla fine della guerra, nel 1945, riprese l'attività a Pisa, tenendo per incarico corsi di Analisi superiore, Teoria delle funzioni, Analisi matematica e Meccanica razionale. Nel 1948 conseguì la libera docenza in Analisi e alla fine del 1949 si trasferì negli U.S.A., prima a Cincinnati (dove lavorò con Otto Szasz e Charles N. Moore) e poi a Princeton (dove lavorò con Maston Morse). Nel 1952 vinse il concorso per la cattedra di Analisi dell'Università di Palermo, insegnandovi fino al 1961, quando si trasferì a Modena, dove diede notevole impulso al rilancio di quell'Istituto di Matematica ed al potenziamento della sua Biblioteca e del Seminario Matematico.
La sua produzione scientifica conta più di 60 pubblicazioni, che spaziano su diversi campi dell'Analisi: equazioni differenziali, serie di Fourier e sviluppo in serie di funzioni ortonormali, topologia delle varietà, Analisi reale, Calcolo delle variazioni e Teoria delle funzioni. Vincitore del premio Michel per la migliore tesi di laurea a Pisa, ottenne pure (1940) il premio Merlani dell'Accademia delle Scienze di Bologna per i "contributi relativi a questioni di calcolo delle variazioni".
Necrologio: "Atti del Seminario Matematico e Fisico dell'Università di Modena", vol. XXXIII (1984), pp. II-XIV (C.Vinti); "Annuario dell'Università di Modena", 1984, pp. 1-11 (F.Barbieri & C.Vinti).
Codazza Giovanni

Giovanni Codazza era nato a Milano il 15 maggio 1816; è morto a Como l'1 settembre 1877.
Laureatosi in Ingegneria a Pavia nel 1837, fu dapprima insegnante di scuole medie. Nel 1842 fu nominato professore di Geometria descrittiva all'Università di Pavia, di cui fu anche rettore nel 1857-'58, mentre nel 1862-'63 fu sindaco della città. Nel 1863 passò al Politecnico di Milano alla cattedra di Fisica tecnologica e nel 1867 a quello di Torino per Fisica industriale.
Lasciò una quarantina di pubblicazioni, prevalentemente di Fisica. Fu socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Istituto Lombardo.
Necrologio: Trans. Lincei, (3) 2 (1877-78), pp. 22-24 (Q. Sella).
Cibrario Cinquini Maria
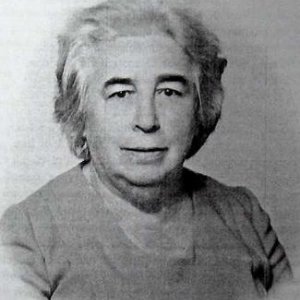
Maria Cibrario Cinquini era nata a Genova il 6 settembre 1906; è morta a Pavia il 16 maggio 1992.
Si era laureata a Torino nel 1927 sotto la direzione di Guido Fubini e già nel 1932 aveva conseguita la libera docenza in Analisi. Aveva iniziato la carriera universitaria a Torino nel 1928 come assistente di Peano e dopo la sua scomparsa (1932) fu assistente di Tricomi. Dopo il matrimonio con Silvio Cinquini, nel 1939 si era trasferita nell'Università di Pavia come assistente e professore incaricato. Nel 1947 vinse il concorso a professore ordinario di Analisi e, dopo un quadriennio trascorso prima a Cagliari e poi a Modena, fu richiamata a Pavia nel 1950 e vi rimase fino al collocamento a riposo (1980).
Maria Cibrario Cinquini
La sua attività scientifica, attestata da un centinaio di pubblicazioni, è dedicata in massima parte alle equazioni a derivate parziali ma tocca anche altre varie questioni dell'Analisi: trasformata di Laplace, numeri e polinomi di Bernoulli, problemi di minimo, rapporti tra serie di polinomi sferici generalizzati e serie trigonometriche riguardanti funzioni ipergeometriche di Gauss. Si è occupata anche di questioni geometriche sulle congruenze di rette iperspaziali e sulla estensione dei metodi della Geometria descrittiva dallo spazio ordinario a quello a quattro dimensioni per rappresentare le rigate e certe varietà di piani.
Nel 1981 aveva ricevuto la nomina a professore emerito di Analisi matematica. Fu socio dell'Accademia dei Lincei e di altre Accademie locali.
Necrologio: Bollettino UMI, (7) 8-A (1994), pp. 295-307 (M.G. Cazzani Nieri).
Segre Corrado

Corrado Segre era nato a Saluzzo (Cuneo) il 20 agosto 1863; è morto a Torino il 18 maggio 1924.
Si laureò in Matematica nel 1883 nell'Università di Torino, in cui si svolse l'intera sua carriera, prima (1883-'88) come assistente di Enrico D'Ovidio e Francesco Faà di Bruno, poi, a partire dal 1888, come professore di Geometria superiore.
“L'opera di Corrado Segre, come scienziato e come Maestro, è parte viva e integrante di quel rigoglioso sviluppo delle discipline geometriche, che si è affermato in 1talia, dalla metà del secolo scorso in poi, con un poderoso “crescendo”, e sorpassando di gran lunga, in taluni campi, i contributi di ogni altro paese” (G. Fano).
L'opera personale di Segre si è esplicata principalmente nella Geometria proiettiva degli iperspazi e nella prima fase della Geometria algebrica (quella sulle curve), nonchè nei primi sviluppi della Geometria proiettivo-differenziale. Tuttavia, per quanto importanti siano stati i suoi personali contributi a queste teorie, ancora più notevole fu la sua diuturna, impareggiabile opera di Maestro che, per oltre un trentennio, si estese ben oltre Torino e gli assicurò un'universalmente riconosciuta posizione di capo-scuola della Geometria italiana, i cui maggiori cultori, anche del periodo successivo (Castelnuovo, Enriques, Severi, ...), furono tutti, direttamente o indirettamente, suoi allievi.

Corrado Segre
Il nome di Segre resta legato all'invariante (birazionale) di Zeuthen-Segre delle superfici algebriche e alle tangenti e linee di Segre nella Geometria proiettivo-differenziale delle superfici. Lasciò un centinaio di pubblicazioni e una trentina di quaderni manoscritti, che rispecchiano i corsi svolti sia all'Università sia alla Scuola di Magistero. Fu socio dell'Accademia dei Lincei, di quella di Torino e di molte altre italiane e straniere; nel 1898 divise col Volterra il premio reale dei Lincei.
Nel 1928 la Facoltà di scienze di Torino appose, su una parete del palazzo universitario di via Po, un ricordo marmoreo di Segre (lapide con medaglione) che andò distrutto nei bombardamenti aerei del 1943. Una via di Torino porta il suo nome.
Necrologio: “Rend. Lincei”, (5) 3311 (1924), pp. 353-359 (G. Castelnuovo); “Boll. UMI”, 6 (1927), pp. 276-289 (H. F. Baker); ecc.
Burgatti Pietro

Pietro Burgatti era nato a Cento (Ferrara) il 27 febbraio 1868; è morto a Bologna il 20 maggio 1938.
Laureatosi nel 1893 all'Università di Roma, vi rimase parecchi anni come assistente e libero docente di Analisi infinitesimale e di Meccanica, finché nel 1908, in seguito a concorso, fu nominato professore di Meccanica razionale all'Università di Messina da dove, nello stesso anno, passò a quella di Bologna.

Pietro Burgatti
Ha lasciato un centinaio di pubblicazioni, prevalentemente di Meccanica e di Fisica matematica, ma anche alcune di Analisi e di Astronomia. S'interessò pure molto del calcolo vettoriale, collaborando con Cesare Burali-Forti e Roberto Marcolongo alla loro "Analyse vectorielle" ma con minore fanatismo di altri vettorialisti. Ottimo insegnante, scrisse un valido e noto trattato di Meccanica razionale.
Fu socio dell'Accademia di Bologna, dell'Accademia dei Lincei e vice-presidente dell'UMI.
Necrologio: "Bollettino UMI", 17 (1938), pp. 145-156 (D. Graffi).
Menabrea Federigo
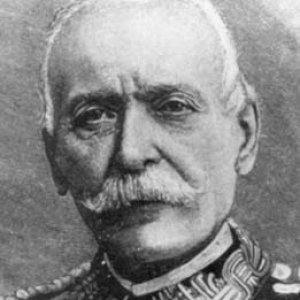
Federigo Luigi Menabrea, marchesese di Valdora, era nato a Chambery (Savoia) il 4 settembre 1809; è morto a St Cassin il 25 maggio 1896.
Federigo Menabrea
Come ricercatore, fu un precursore dell'introduzione di concetti energetici nella meccanica dei continui. Oggi, il suo nome viene soprattutto ricordato in connessione con il teorema sul minimo del lavoro elastico di deformazione, la cui importanza tecnica fu posta in luce più tardi da Castigliano. Ebbe una lunga disputa con Felice Chiò, a proposito di un errore di Lagrange (ma era Chiò ad avere ragione).
Era socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Torino. Nel 1859 ricevette il Collare dell'Annunziata e nel 1861 il titolo ereditario di Conte.
Necrologio: Suppl. ai Rend. Circ. Mat. Palermo, 5 (1910), pp. 21-24; Atti Accad. Sci. Torino, 31 (1895-96), pp. 851-52.