Search
Ciclo di conferenze “Matematica e …” a Urbino 2010/2011
Notari Cuzzer Vittoria

Vittoria Notari Cuzzer era nata a Reggio Emilia il 17 aprile 1894; è morta a Roma il 18 luglio 1976.
Terza di otto fratelli, deve il suo nome ad un evento curioso: il giorno della sua nascita transitava per Reggio il treno speciale dell'allora Regina Vittoria d'Inghilterra.
Per volere della famiglia, frequentò la Scuola Normale (oggi Istituto Magistrale) e, ottenuto il relativo diploma, insegnò nella scuola elementare di Barco (RE) dal '14 al '16. Lasciò l'insegnamento elementare perché, appassionatasi agli studi di Matematica e conseguita privatamente la maturità tecnica, si iscrisse al corso laurea in Matematica presso l'Università di Bologna mantenendosi agli studi con lezioni private.

Vittoria Notari Cuzzer
Appena laureata con il massimo dei voti e la lode, avendo come relatore Federigo Enriques, nel 1920-21 ne divenne assistente volontario. In seguito, fu assistente di ruolo di Beppo Levi a Parma e di Guido Castelnuovo, Federigo Enriques e Ugo Amaldi a Roma. Nel 1933, ritenendo incompatibile gli oneri familiari con i doveri accademici, passò all'insegnamento medio e per lungo tempo insegnò Matematica e Fisica presso il Liceo classico “T. Tasso” di Roma.
La sua produzione scientifica, continuata fino a tarda età, si è svolta – sotto la guida di Enriques – nell'ambito della Geometria algebrica e della didattica della Matematica, con una collaborazione attiva alla Serie quarta (quella iniziata da Enriques nel 1922) del Periodico di Matematiche.
Amaldi Ugo

Ugo Amaldi era nato a Verona il 18 aprile 1875; è morto a Roma l'11 novembre 1957.
Nel 1898 si laureò in Matematica a Bologna, ove subì specialmente l'influenza di Salvatore Pincherle. Poco dopo (1903) fu nominato professore di Algebra e Geometria analitica a Cagliari, ove rimase due anni. Passò poi all'Università di Modena (1906-1919), a quella di Padova (1919-24) e quindi a Roma, ove insegnò prima nella Facoltà di Architettura (1924-42) e poi in quella di Scienze (1942-44).

Ugo Amaldi
I suoi principali contributi scientifici concernono la Teoria dei gruppi continui di trasformazioni, cui dedicò, fra l'altro, due poderose Memorie (1912-13 e 1918) e un bel volume di Lezioni (Roma, 1942-44). Fu trattatista valente e molto apprezzato e validissimo collaboratore di Tullio Levi-Civita e Federigo Enriques, contribuendo così a creare opere che, senza di lui, o non sarebbero forse state pubblicate o lo sarebbero state in forma meno brillante.
Fu socio dell'Accademia dei Lincei e di altre, da tutti apprezzato anche per l'animo buono, giusto e sereno; fu uomo di sincera, mai ostentata, religiosità.
Necrologio: "Bollettino UMI", (3) 12 (1957), pp. 726-730, a cura di T. Viola; "Atti Accademia Scienze Torino", 92 (1957-58), pp. 687-695, a cura di A. Terracini.
Loria Gino
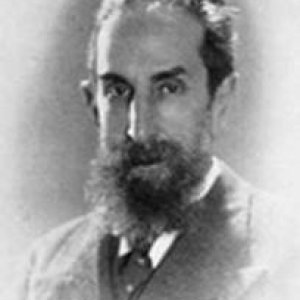
Gino Loria era nato a Mantova nel 1862; è morto a Genova il 30 gennaio 1954. Era fratello del noto economista Arturo.
Laureatosi nel 1883 all'Università di Torino, vi rimase tre anni come assistente di Enrico D'Ovidio. Nel 1886, a soli 24 anni, fu nominato, in seguito a concorso, professore di Algebra e Geometria analitica all'Università di Genova, dove sempre rimase.
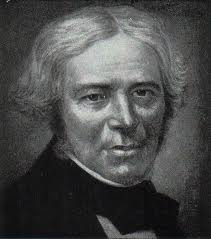
Gino Loria
Loria fu essenzialmente un cultore di storia della Matematica, a cui dedicò un gran numero di lavori e anche di libri, ma alla quantità della sua produzione non s'accompagna sempre una qualità uniforme. Tuttavia alcuni suoi libri, specie quelli sulle curve speciali, ebbero successo e furono anche tradotti in tedesco.
Durante le persecuzioni antiebraiche, trovò efficiente rifugio nelle comunità protestanti della val Pellice.
Fu socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia di Torino.
Necrologio: Rendiconti Lincei, (8) 17 (1954), pp. 402-21 (A. Terracini); Bollettino della Unione Matematica 1taliana, (3) 9 (1954), pp. 115-118 (E . Togliatti ).
Peano Giuseppe
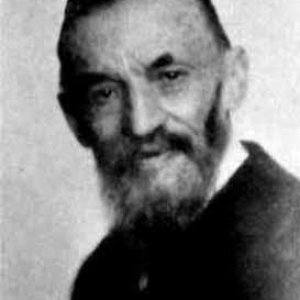
Giuseppe Peano era nato a Spinetta di Cuneo, da umile famiglia, il 27 agosto 1858; è morto a Torino il 20 aprile 1932.
Si laureò all'Università di Torino nel 1880, rimanendovi subito dopo come assistente di Angelo Genocchi. Insegnò poi all'Accademia militare e nel 1890 successe a Genocchi all'Università, insegnandovi Calcolo infinitesimale sino al 1925 e poi, sino alla morte, Matematiche complementari.
Peano è stato indubbiamente uno dei più grandi matematici italiani degli ultimi decenni dell'Ottocento e il suo nome resta legato, assieme a quelli di Cauchy, Weierstrass, Dini, alla sistemazione rigorosa dell'Analisi. I postulati aritmetici, la curva che porta il suo nome (curva continua che riempie tutto un quadrato), il teorema di esistenza per le equazioni differenziali ordinarie, restano pietre miliari nella storia della Matematica. Tuttavia la sua opera non fu sempre accompagnata da un unanime consenso, “ciò che forse si spiega tenendo conto che Peano fu un precursore di certi moderni sviluppi della matematica («bourbakismo») che, anche pel loro spirito spesso aggressivo e iconoclastico, incontrano tuttora vivaci resistenze. In Peano però non c'è traccia di certo moderno malcostume di rendere le cose artificialmente difficili e complicate, anzi uno dei suoi lineamenti migliori fu lo spirito semplificatore, che si rivelò soprattutto nella geniale semplicità di certi suoi classici esempi mostranti la non generale validità di alcuni fondamentali teoremi del Calcolo” (Tricomi).

Giuseppe Peano con la sua famiglia
Fra le sue pubblicazioni occupa un posto a parte il "Formulario Mathematico" (varie edizioni dal 1895 al 1908). Dall'inizio del Novecento, Peano andò sempre più estraniandosi dalla ricerca Matematica attiva, finendo con l'interessarsi quasi esclusivamente delle lingue internazionali ausiliarie (latino sine flexione). Di conseguenza, il suo insegnamento universitario andò gradualmente perdendo di efficacia perché, come disse il suo allievo Beppo Levi (1875-1961), "l'apostolo limitò l'opera del matematico e ne impedì talvolta la completa estimazione".
Fu socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia delle Scienze di Torino. Dal 1953, il Liceo scientifico di Cuneo è a lui intitolato e una via di Torino porta il suo nome.
Necrologio: Bollettino UMI, 11 (1932), pp. 253-262 (B. Levi); Rend. Semin. Milano, 7 (1933), pp. 323-389 (U. Cassina).
Opere: a cura dell'UMI, 3 voll. (Roma, 1957-59).
Sannia Achille

Achille Sannia era nato a Campobasso il 22 aprile 1823; è morto a Napoli l'8 febbraio 1892.
Dal 1856 diresse a Napoli una scuola privata di Matematica che, prima del '60, ebbe maggior prestigio ed efficienza dell'Università. Qui i suoi principali collaboratori furono Enrico D'Ovidio e Nicola Salvatore-Dino. Nel 1865, chiuso lo studio privato, Sannia passò ad insegnare Geometria proiettiva all'Università partenopea.
Ebbe varie cariche pubbliche, fra cui quella di Deputato al Parlamento per il collegio di Morcone (Benevento). Nel 1890 fu nominato Senatore del Regno.
Le sole pubblicazioni scientifiche di Sannia, che fu soprattutto un valente maestro, sono un trattato di Geometria proiettiva e un assai noto trattato di Geometria elementare in collaborazione col suo allievo D'Ovidio.
Fu socio dell'Accademia delle Scienze e della Società Pontaniana di Napoli. Un suo busto è conservato nella Scuola degli Ingegneri di Napoli.
Necrologio: “Rendiconti Circolo Matematico Palermo”, 6 (1892), pp. 48-51 (G. Torelli).
Vailati Giovanni

Giovanni Vailati era nato a Crema (Cremona) il 23 aprile 1863; è morto a Roma il 14 maggio 1909.
Laureatosi in Ingegneria e poi in Matematica a Torino, fu assistente di Giuseppe Peano, di cui senti grandemente l'influenza. Passò poi “alle dipendenze” di Vito Volterra, in quegli anni a Torino, e tenne dei corsi di Storia della meccanica con tre prolusioni (negli anni alla fine del secolo) che sono tra i suoi scritti più apprezzati. Lasciato il “precariato” universitario, Vailati passò all'insegnamento medio e da ultimo fu membro molto attivo di una Commissione reale per la riforma delle scuole secondarie italiane.

Giovanni Vailati
Vailati fu principalmente un filosofo e uno storico della Scienza, dotato di interessi culturali vastissimi, oltre che un poliglotta. La sua opera contribuì a mostrare la vanità di ogni studio della Storia della Filosofia che prescinda dalla Scienza e questa sua impostazione (che lo metterà in contatto, tra gli altri, con Federigo Enriques) era all’inizio del Novecento lungi dall'essere una verità da tutti accettata.
Necrologio: “Bollettini Conti”, 8 (1909), pp.206-216 (Peano, Marcolongo, Padoa, A. Conti).
Opere: Firenze, Seeber-Leipzig, Barth, 1911.
Rosati Carlo

Carlo Rosati era nato a Livorno il 24 aprile 1876; è morto a Pisa il 19 agosto 1929.
Laureatosi a Pisa nel 1897, allievo della "Normale" , fu dapprima (1897-99) assistente di Ulisse Dini per l'Analisi infinitesimale. Poi, insegnò per 24 anni nelle scuole medie; da ultimo, fu professore all'Istituto tecnico di Pisa finché nel 1923, risultato secondo nella terna di vincitori al concorso di Geometria proiettiva e descrittiva dell’Università di Parma, fu nominato docente di questa disciplina all'Università di Pisa, dove rimase sino alla prematura, improvvisa morte.
Carlo Rosati è autore di una ventina di lavori prevalentemente di Geometria algebrica, fra cui prevalgono quelli dedicati alla classificazione dei corpi di funzioni abeliane.
Necrologio: “Bollettino Matematico Conti”, 8 (1929), pp. 121-128 (L. Puccianti e G. Scorza).
Barsotti Iacopo
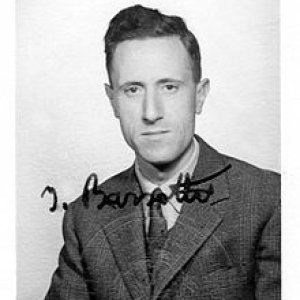
Iacopo Barsotti era nato a Torino il 28 aprile 1921; è morto a Padova il 27 ottobre 1987.
Aveva studiato alla "Normale" di Pisa e si era laureato nel 1942. Assolti gli obblighi militari, era tornato a Pisa come perfezionando alla stessa Normale. Fu assistente a Roma, con Francesco Severi, dal 1946 al 1948 e poi si trasferì negli Stati Uniti: dapprima come "fellowship" a Princeton e poi come "full professor" all'Università di Pittsburgh (fino al 1960) e alla Brown University. Primo ternato in un concorso di Geometria, fu chiamato a Pisa nel 1961 come docente di Geometria e, successivamente, di Algebra. Nel 1968 si trasferì a Padova, dove insegnò Geometria fino alla morte.
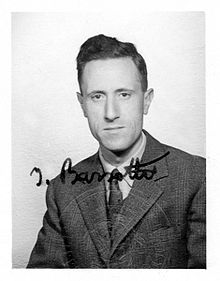
Iacopo Barsotti
La sua produzione scientifica, che conta una cinquantina di lavori, comprende contributi alla teoria delle algebre, ai fondamenti della Geometria algebrica e soprattutto, nell’ambito di queste discipline, risultati fondamentali relativi alle varietà abeliane e, più generalmente, alla struttura delle varietà gruppali. Di Barsotti va ricordata anche la costruzione di gruppi analitici associati alle varietà abeliane che sono oggi noti con il nome di gruppi di Barsotti-Tate e sono all’origine della cosiddetta coomologia cristallina. Di interesse sono anche gli studi connessi alle funzioni theta, da lui generalizzate introducendo la classe di funzioni tipo-theta. Le metodologie impiegate nei suoi lavori riflettono i contatti che egli aveva avuto con l'ambiente internazionale, cui si era forse accostato per superare il disagio che gli derivava dall’isolamento in cui per un certo periodo si era trovata la Matematica italiana.
Castelnuovo Guido
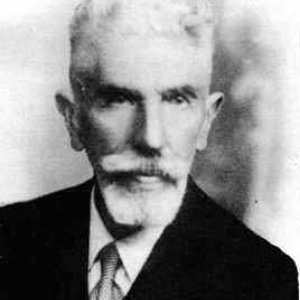
Guido Castelnuovo era nato a Venezia da Enrico, noto letterato, il 14 agosto 1865; è morto a Roma il 27 aprile 1952.
Dopo aver frequentato il Liceo “Foscarini” di Venezia (dove l'efficace insegnamento di Aureliano Faifofer contribuì ad indirizzarlo alla Matematica), si laureò a Padova nel 1886. Qui, tra gli altri, ebbe come maestro Giuseppe Veronese. Fu quindi a Roma per un breve periodo (1886-87) di perfezionamento sotto Luigi Cremona, per recarsi poi a Torino dove, dal 1887 al 1891, fu assistente di Enrico D'Ovidio e strinse amicizia con il quasi coetaneo Corrado Segre. Il periodo torinese fu determinante per il suo orientamento scientifico. Divenuto nel 1891 professore di Geometria all'Università di Roma, vi rimase per tutto il resto della sua lunga e fruttuosa carriera.
Castelnuovo fu, assieme a Corrado Segre, a Federigo Enriques (suo cognato) e a Francesco Severi, il fondatore della scuola italiana di Geometria algebrica che, per alcuni decenni, assicurò all'Italia una posizione di assoluto primato in questo settore della ricerca matematica. In particolare si debbono a Castelnuovo le condizioni necessarie e sufficienti per la razionalità delle superfici algebriche, la dimostrazione della razionalità dell'insieme delle involuzioni piane e lo studio approfondito delle superfici irregolari. L'attività di Castelnuovo nella Geometria algebrica si arresta però, salvo sporadici contributi posteriori, intorno al 1906. Nell'epoca successiva, il suo interesse fu attirato da altre questioni e principalmente dal Calcolo delle probabilità, a cui dedicò un trattato in due volumi (prima edizione 1918) che per lunghi anni fece testo in materia.
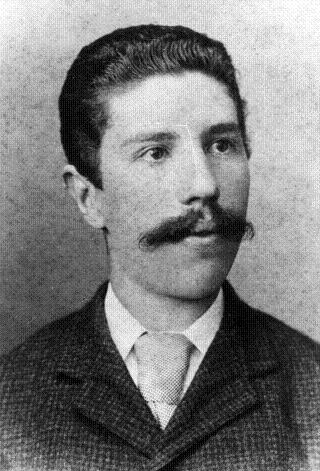
Guido Castelnuovo
Le persecuzioni razziali, scatenatesi quando era già a riposo, circondato da generale ammirazione e simpatia, non lo toccarono direttamente salvo la necessità di nascondersi per qualche mese. Dopo la liberazione di Roma nel 1944 fu nominato Commissario del CNR, di cui inizia il risanamento. Nei “vivaci” mesi di quel periodo viene però sospeso bruscamente dal suo incarico. Successivamente (1945) contribuì più efficacemente di tutti alla rinascita dell'Accademia dei Lincei (soppressa dal fascismo nel 1939) di cui fu il primo, autorevolissimo, presidente sino alla morte. Dal 1949 fu uno dei soli cinque Senatori a vita previsti dalla nuova Costituzione italiana.
L'Istituto matematico dell'Università di Roma è a lui intitolato. All'Accademia dei Lincei vi è un medaglione in suo ricordo.
Necrologio: "Accademia dei Lincei", fascicolo speciale del 1953 (G. Fano); Bollettino UMI, (3) 7 (1952), pp. 241-46 (L. Campedelli).
Opere: Memorie scelte (Bologna, Zanichelli, 1937).